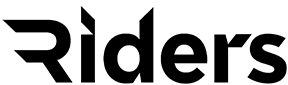Parliamo di nomi strani, di una Romagna povera e di un pilota che ha scritto otto anni di storia Ducati e che ora saluta tutti
Articolo di Marco Masetti | Foto Ducati

Prima che il turismo e il boom economico portassero un diffuso benessere, il mio era un paese povero. A parte i “signori”, ristretta minoranza, il resto si arrangiava lavorando dove capitava, tra terra e mare, qualche volta emigrando al Nord o all’estero. Non è la storia di uno sperduto paesino lontano dalle rotte economiche, ma di una località di villeggiatura della Romagna dove oggi vedi gente che si rilassa o si diverte, ostentando un benessere che probabilmente non ha. Ma questo è un altro discorso… Torniamo al mio paese: molti erano proletari, parola antica che nella Roma antica significava che l’unica ricchezza di famiglia erano i figli, che erano tanti. Infatti, fino a pochi decenni addietro, trovavi gente che si chiamava Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e via fino a Ultimo, così battezzato nella speranza che dopo di lui non arrivassero altre bocche da sfamare. Ma la Romagna è sempre stata estrosa, soprattutto nel dare nomi ai figli: Radames, Negadio, Sperandio, ma anche Sceridan, Milkana, Cicles, senza dimenticare quelli che mettevano ai figli nomi politici: ci sono Veridea, Vladimiro, una raffica di Benito e via scivolando verso i tanti Jarno, Kevin e Barry testimoni dell’incommensurabile amore per il “motore” diffusissimo nella mia terra d’origine. Spesso fanno sorridere o pensare ai tanti problemi avuti nella vita da chi si è ritrovato con un nome impegnativo da portare e ha dovuto ricorrere alla classica formula “detto…”, con la quale una persone sceglie di farsi chiamare con un nome più banale ma portabile. Tra tutti i folli nomi romagnoli uno è terribile: Antavlèva. Traduco per i non romagnoli: “non ti volevo”. Il figlio indesiderato, magari “della colpa” come si diceva una volta. Una negazione, sincera ma terribile, un vero nome importabile. Probabilmente Antonio, un ragazzo siciliano trapiantato nel forlivese, quando venne il momento di battezzare suo figlio, non conosceva l’esistenza di questo terribile nome. E saggiamente lo battezzò Andrea. Cognome? Dovizioso.
La storia però è bizzarra e Andrea, anno dopo anno, è diventato per la famiglia Ducati, un piccolo Antavlèva. Uno che ha scritto la storia della Casa italiana ma non è mai stato amato del tutto. Uno che quando c’è da cambiare, tagliare, sostituire, è sempre il candidato numero uno a far le valigie. Eppure è in rosso dal 2013, un’epoca lontana nella quale correvano Ben Spies e Colin Edwards, Lorenzo e Pedrosa. C’erano le CRT, le MotoGP dei poveri con la quali sfrecciavano (si fa per dire… Johnny Hernandez, Claudio Corti, Bryan Staring e Hiroshi Aoyama.
Andrea c’era già, pronto ad accogliere l’arrivo dell’ingegner Dall’Igna, il tecnico che ha riportato la Ducati al vertice dopo il biennio nero di Rossi.
Forte, vincente, mai amato: il destino di Dovizioso è questo, quello di un pilota esperto, intelligente, capace di far crescere tutto quello che ha attorno. Modernissima e difficilmente comprensibile figura di leader umile, uno apparentemente normale ma capace di grandissime imprese. Come quella di lasciare la Ducati nel giorno in cui sale sul gradino più alto del podio. Non interessano più di tanto le motivazioni dell’addio, è significativo pensare che in un mondo in cui si ragiona a bienni, ovvero dove contratti e progetti hanno una durata media di due anni, Andrea sia rimasto otto anni e che abbia triturato sempre la concorrenza. Quando arrivò a Borgo Panigale, Dall’Igna si trovò due piloti italiani: Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Uno contro l’altro, ben poco compagni. Sembrava facile per Iannone vincere la partita e invece è andata come è andata e Dovi è stato l’unico “anti-” degli ultimi tre anni. Fate voi, cari manager Ducati, Antavlèva se ne va, forse lo rimpiangerete.