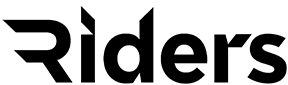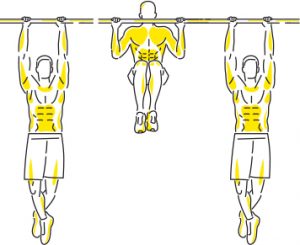La Parigi-Dakar è inafferrabile, crudele ma indimenticabile. È una gara che ti entra dentro e ti fa fare i conti con te stesso. Ecco i protagonisti della prossima edizione
Un’opera incompiuta. È così che vedo la mia esperienza alla Dakar. Tre edizioni, una partecipazione portata in fondo, e tante, tantissime sensazioni, così differenti e contrastanti, da farmele avvertire appieno nello stomaco. Ci sono stata tre volte, nel 2011, nel 2012 e nel 2014. Quando penso alla Dakar è come se mi riferissi a una cosa sola; un’entità enigmatica, una sorta di divinità ultraterrena che mi ha seguito col suo spirito immortale. Come una donna travolgente, capace di condurti nell’Olimpo dei desideri più seducenti, per poi trascinarti giù negli abissi della disperazione un attimo dopo. Volubile e capricciosa, irresistibile.
La mia prima Paris Dakar
 La mia esperienza con il più classico e leggendario dei rally è iniziata per caso. Da sempre grande appassionata di 4×4, dai 18 anni in poi sono sempre andata per boschi col mio Wrangler TJ, una Jeep che considero un’estensione del mio Io. È così simile a me nei suoi tratti caratteriali: esibizionista all’apparenza ma rude nel profondo, con una personalità forte ma comunque bisognosa di cure.
La mia esperienza con il più classico e leggendario dei rally è iniziata per caso. Da sempre grande appassionata di 4×4, dai 18 anni in poi sono sempre andata per boschi col mio Wrangler TJ, una Jeep che considero un’estensione del mio Io. È così simile a me nei suoi tratti caratteriali: esibizionista all’apparenza ma rude nel profondo, con una personalità forte ma comunque bisognosa di cure.
Sono sempre stata affascinata dalle grandi imprese; ma naturalmente mai avrei immaginato di arrivare a vivere la più maestosa delle avventure. Sono approdata alla Dakar 2011 quando mi è stato chiesto di sostituire un copilota su una macchina pochi mesi prima della gara. Incredula, mi sono messa al lavoro per cercare di imparare il più possibile sulla sfida in cui stavo per buttarmi. Esami medici, licenze di rally, corsi accelerati di navigazione e via in Sudamerica.
Arrivare a Buenos Aires in quel periodo è stato surreale
Erano gli ultimi giorni di dicembre e in giro c’era una quantità tale di piloti, meccanici e mezzi di ogni genere da invadere la metropoli intera. Caldo afoso, sole abbagliante e una baraonda continua di persone che si aggiravano per le strade. Motori, risate chiassose, tinte sgargianti dei colori dei team. Un’enorme festa in cui nell’aria si respirava adrenalina, tensione, felicità, pura gioia di vivere. L’anima della Dakar era lì, e si era impadronita della città. Ancora non lo sapevo, ma di lì a poco avrebbe travolto anche me.
Giornate in officina per mettere a punto i mezzi, provare le cinture, regolare i sedili. Poi le verifiche tecniche e amministrative. Caos, gente che si salutava rivedendosi dopo un anno, persone che correvano da tutte le parti, leggende viventi a fianco di persone qualunque, catapultate lì, come me. Non sapevo bene cosa aspettarmi, ma sapevo che mi stava piacendo.
Alla partenza
 Una folla immensa di spettatori acclamava piloti sconosciuti alla stregua di miti consacrati, facendo sentire chiunque protagonista del proprio sogno. Da quel momento in poi la festa sarebbe finita, lasciando il posto a un’avventura all’insegna di nuovi stimoli, tra fatica e disagio, attraverso migliaia di chilometri di piste da aggredire voracemente e momenti contemplativi, immersi in paesaggi incontaminati. Un viaggio sul mondo e attraverso il mondo.
Una folla immensa di spettatori acclamava piloti sconosciuti alla stregua di miti consacrati, facendo sentire chiunque protagonista del proprio sogno. Da quel momento in poi la festa sarebbe finita, lasciando il posto a un’avventura all’insegna di nuovi stimoli, tra fatica e disagio, attraverso migliaia di chilometri di piste da aggredire voracemente e momenti contemplativi, immersi in paesaggi incontaminati. Un viaggio sul mondo e attraverso il mondo.
La prima esperienza è terminata presto, quarta tappa: ritiro per problemi meccanici. Però ho fatto la conoscenza di ciò che si sarebbe poi rivelato un amore dolce, puro ed eterno: il camion. Sono stata recuperata da un Mercedes Unimog guidato da un mio compagno di team: il veterano, nonché vincitore della Parigi-Dakar 1986, Giacomo Vismara.
Forse perché ho sempre avuto un debole per le esperienze più originali e atipiche; forse perché ho sempre guardato con ammirazione alle sfide più inconsuete; ma quel bisonte mi sembrava racchiudere tutta la magnificenza della Dakar. Dunque, se la prima volta c’ero arrivata per caso, la seconda sarebbe stata dettata da scelte ben precise.
La mia seconda Parigi Dakar
Mi sono organizzata per tornare l’anno successivo a correre su un camion. È stata meravigliosa. Estremamente devastante, ma di una bellezza sconvolgente. Dall’esterno la Dakar sembra una gara adrenalinica e fisicamente ardua. Quello che non si vede è il suo aspetto più intimo, ma anche più importante: quello umano.
È un vortice di emozioni potentissime che si avvertono nel corpo e nella mente, e riportano alla dimensione animale di uomo nella natura. Sensazioni forti, per chi aggredisce la vita assaporandone ogni aspetto, cercando di oltrepassare i confini conosciuti, inseguendo nuove sfide e avventure mai provate.
Si vive in condizioni estreme, in cui a risentirne non è solo il corpo. Il centro di controllo è la testa, quella con cui si deve fare quotidianamente i conti e la spinta motivazionale è indispensabile per stringere i denti.

La Dakar è la gara delle grandi contraddizioni
È meravigliosa e crudele allo stesso tempo. È incredibilmente straordinaria perché ti conduce in luoghi primitivi e ti fa ammirare dei paesaggi che difficilmente si possono descrivere in modo realistico.
All’inizio la cosa è divertente, divertente davvero. Attraversi un territorio che cambia continuamente, a distanza di poche decine di chilometri: terra, sabbia, fango, ghiaia, roccia. Sfrecci via su piste di terra dura rapide e scorrevoli che poi iniziano a essere più sabbiose e di lì a poco incontri le dune.
Ti godi il deserto e i suoi colori ambrati, ti senti piccolo e insignificante in mezzo all’infinito. Fai i conti con le trappole che nasconde, i passaggi difficili ma vedi cose indescrivibili e ne catturi ogni dettaglio, dalle pietre ai canyon. Il fisico inizia a sentire qualche colpo più duro: il camion è molto rigido e le botte su schiena e ventre si fanno sentire.
Che festa!
Quattordici lunghe e fottutissime tappe, sconvolgenti e massacranti; diecimila chilometri attraversando Argentina, Cile e Perù, culminate a Lima in una festa caotica e disorientante, in cui un pubblico in estasi mi acclamava come una celebrità. Lo stesso pubblico che tutti i giorni si radunava lungo le strade per vedere il rally passare, salutando e trasmettendo una botta di energia quando la stanchezza sembrava insostenibile.
Il calore umano era protagonista anche nel bivacco, dove si arrivava la sera alla fine di ogni giornata. Un enorme campo organizzatissimo con mensa, bagni chimici e, tutto intorno, i team con le loro assistenze.

Il villaggio non dormiva mai, testimone di gioie e frustrazioni dove, stremati e affamati, si assaporava la dolce sensazione di leggerezza dell’essersi lasciati alle spalle un’altra tappa e di aver fatto un passo in più verso l’arrivo. Un microcosmo illuminato e rumoroso, con i meccanici intenti a lavorare tutta le notte per riparare i mezzi, sgasare per testare le modifiche fatte, parlate nervosamente e sperare che tutto fosse pronto prima del mattino seguente. Dalla tenda in cui dormivo sentivo tutto questo, ma non era irritante. Erano i suoni della Dakar.
Delusioni
Si è portati a pensare che eventi significativi come questa uniscano le persone. Capita, tuttavia, che quest’ultime deludano in modo brutale. È ciò che è accaduto durante la mia terza e (spero, per ora) ultima Dakar. Il team era lo stesso con cui avevo fatto le altre e, soprattutto, portato a termine l’edizione di due anni prima. Credevo di aver stabilito con loro un legame particolare, ma purtroppo il sentimento non era reciproco.
Nel 2014 sono tornata in Argentina carica di entusiasmo e speranze ma, fin dal primo giorno, i fatti hanno mostrato una situazione difficile da superare. Le tappe erano molto lunghe, caratterizzate da prove speciali complesse che richiedevano grande sforzo e abilità, accompagnate da trasferimenti interminabili. Il motivo principale è da attribuire a un problema organizzativo del team di cui facevo parte, legato al modo di gestire la gara da chi stava “in alto”.
Una vera e propria truffa
Iscritta come camion in gara, mi sono ritrovata a dover fare un lavoro di assistenza a una macchina del team, nonostante questi non fossero i patti. Io e Beppe Fortuna siamo stati vittime inconsapevoli di un team manager che, alla guida dell’auto, aveva subdolamente preso accordi con il pilota del nostro camion perché questi lo seguisse come un’ombra durante tutta la gara. Una situazione a dir poco paradossale e chiaramente insostenibile.
Ho sperato fino all’ultimo che la fortuna ci assistesse, ma nel profondo avevo la consapevolezza che troppe cose stavano andando storte, anche considerando che, soprattutto negli ultimi giorni, eravamo riusciti a rimanere in gara per manciate di minuti.
Stavamo tirando troppo la corda e da un momento all’altro si sarebbe potuta spezzare. Cosa che è accaduta dopo la decima tappa, quando una mattina siamo arrivati oltre il tempo massimo imposto dal regolamento. Dieci giorni massacranti erano stati inutili. Una delusione immensa e una rabbia ancora più grande. Una gara, se così la si può definire, buttata via.
Crudele ma bellissima
 Un’altra delle svariate contraddizioni della Dakar: perché non conta quanto la Dakar sia crudele, rimane comunque splendida. È carica di una forza oscura che ti attrae nonostante la tristezza che a volte ti lascia dentro. Sarà che comunque si dimostra essere un’esperienza di vita tutta concentrata in due settimane piene di emozioni, così contraddittorie e in antitesi tra loro, che alla fine ti fa essere grato di averla vissuta. E io l’ho assaporata tutta, nel bene e nel male.
Un’altra delle svariate contraddizioni della Dakar: perché non conta quanto la Dakar sia crudele, rimane comunque splendida. È carica di una forza oscura che ti attrae nonostante la tristezza che a volte ti lascia dentro. Sarà che comunque si dimostra essere un’esperienza di vita tutta concentrata in due settimane piene di emozioni, così contraddittorie e in antitesi tra loro, che alla fine ti fa essere grato di averla vissuta. E io l’ho assaporata tutta, nel bene e nel male.
Il fascino della Dakar risiede tutto nella sua indole selvaggia: è bella, è primitiva, è esigente. Richiede enormi sforzi e pretende un amore incondizionato. È audace, è sensuale, è brutale. Di una bellezza immateriale e inafferrabile. Sa dare tanto, ma sa anche essere intrattabile. Ci vuole passione, ma anche pazienza. Ci vuole passione, quindi anche pazienza.
Articolo di Eleonora Dal Prà
Foto di Federico Guida
Nelle foto: Roberto “Checco” Tonetti, Tonetti RallyRaid; Jacopo Cerutti, Husqvarna CF Racing Team; Diocleziano Toia, KTM, Malles Moto; Alessandro Botturi, Yamalube Yamaha Official; Antonio Cabini, PanDakar Orobica Raid Team