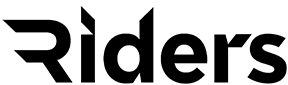Una chiacchierata con Stefano Bottoni. Lunga, amichevole, evocativa. Ricca di aneddoti ma, soprattutto, di ricordi. Un’emozione forte, che ha accompagnato ogni tassello di una storia senza paura, Sine Metu. Stefano non è solo il direttore artistico del Ferrara Buskers Festival – uno degli eventi più rivoluzionari della storia dell’arte recente – ma è una persona che si emoziona perché gli è stato detto che sarebbe piaciuto a Steve Jobs, che dice che parlare di felicità oggi è difficile, ma la musica permette di farlo. Che crede nell’aggregazione che questa sa dare e alla comunione che sa generare. Un uomo consapevole di aver colmato una mancanza grazie a un concatenarsi di eventi e persone che ha permesso a questo Festival di essere, oggi, alla sua trentunesima edizione. Sognatore temerario che odia i cassetti perché «lì dentro i sogni ammuffiscono» Stefano è la metafora del talento: «arricchirsi, prima, per dare agli altri, poi».
Stefano, qual è la tua storia, che cosa ti ha avvicinato all’arte?
«Sono nato nel 1949, lo stesso anno di Bruce Springsteen. Quando l’ho visto cantare a Milano mi sono detto: quello è nato nel mio stesso anno, non è possibile! Probabilmente c’è questo dono di natura che fa sì che una persona si trovi, in un determinato momento della vita, in un certo contesto anziché in un altro. E questo è fondamentale, ci penso spesso. C’è sempre un meccanismo che scatta e lo fa senza che tu lo sappia. Ho frequentato l’istituto d’arte a Ferrara e, dopo l’esperienza da militare, sono entrato nell’officina di mio padre. Fare il fabbro era una scelta quasi monastica».
L’istituto d’arte e l’officina: i due aspetti cardine della tua vita…
«A scuola andavo male nelle materie tecniche, in matematica in particolare. Già mentre andavo all’istituto d’arte cominciai a scrivere canzoni, così mia madre mi regalò una chitarra e io me ne innamorai, come ci si innamora di una ragazza. Da lì con quella chitarra ho girato e sto girando il mondo, la gente mi chiama e io vado: Cuba, Finlandia, Serbia… prendo un aereo e parto, seguendo la voce di chi mi dice: “Vieni qui a suonare». Poi, negli anni Ottanta, c’è stato un passaggio delicato della mia vita, apparentemente impercettibile. Sono stato a Parigi, era l’83, e ho visto un gruppo di musicisti di colore che suonava piccole chitarre rosse. Ho fatto due diapositive, perché allora si facevano le diapositive. E quell’immagine mi è rimasta impressa per anni. Un giorno a Ferrara vidi due ragazze che suonavano il flauto davanti la cattedrale, prima che due vigili urbani arrivassero per mandarle via, perché non si poteva suonare per strada. Quel gesto mi ha colpito, mi ha emozionato. Perché quello che stava succedendo era un momento di aggregazione. Nella mia mente, a distanza di tanti anni, i due episodi si sono accostati. E allora m’inventai un festival. Ancora mi chiedo perché mi è capitata addosso questa strana fantasia, a me, che ero un fabbro!».
Arriviamo così a parlare della nascita del Ferrara Buskers Festival. Come si è giunti alla sua realizzazione?
«Nell’87 il capogruppo della Democrazia Cristiana era Dario Franceschini. È nato tutto in quell’anno grazie a una costellazione di avvenimenti che si sono concatenati. Diedi a Franceschini i documenti con il progetto del Ferrara Buskers Festival. Il nome derivava da una telefonata che feci a un’amica a Londra, chiedendole come si chiamavano lì i musicisti di strada. Lei mi rispose: “Qui li chiamano busker”. Busker, avevo il nome, era perfetto. C’è un aneddoto fondamentale, un passaggio focale: il sindaco di Ferrara, Roberto Soffritti, era stato di recente a New York, a Washington Square, e mentre tornava verso l’hotel il taxi lo aveva lasciato all’ingresso del parco, portandolo a una camminata durante la quale vide dei gruppi che suonavano con centinaia di persone intorno. Quel giorno non pioveva. Se avesse piovuto, questa cosa non sarebbe successa, non ci sarebbe stata nessuna camminata e Roberto Soffritti non sarebbe tornato dal suo viaggio con l’idea di ricreare l’aggregazione che aveva vissuto in quel luogo. Al suo ritorno volle parlare di un festival che fosse in grado di ricreare a Ferrara la stessa cosa. Quell’anno il comune si trovò con un avanzo di bilancio e ciò consentì di avere i fondi necessari a far partire il progetto. Si creò la squadra di lavoro, l’associazione Ferrara Buskers Festival, fondamentale non solo per quell’edizione ma anche per la realizzazione di tutte le successive. Se quel giorno avesse piovuto, noi oggi forse non saremmo qui a parlarne».
Che parole useresti per descrivere lo spirito del Festival?
«Questo Festival ha modificato il sistema di vita nelle città, la sua ideazione è stato un momento storico. Prima non c’era un format che identificasse la figura del busker. Semplicemente non la si conosceva, non era come parlare di jazz. Quando si parlava di busker sorgeva sempre il dubbio: “Busker con la u o con la a?”. La gente all’inizio capiva basket e mi chiamava per chiedermi di organizzare i tornei di pallacanestro. Prima non c’era alcuna letteratura europea a proposito di questo fenomeno. Io quindi inventai qualcosa che nella sua essenza c’era già, perché esistevano i luoghi di unione dei musicisti di strada, ma ne identificai le regole. Da trent’anni chiamo tutti i musicisti, di diverse città, in un unico luogo. Ferrara li chiama tutti a corte. La quotidianità della mia città è cambiata, così come le modalità con cui le persone vanno in vacanza: si va in ferie prima o dopo. Durante si rimane, per stare seduti in terra ad ascoltare gruppi sconosciuti. È diventato un momento di festa. Quando due signore anziane mi dissero: «Grazie per questo pomeriggio di felicità che ci ha dato» capii che era il senso di appartenenza alla musica che aveva dato vita a quelle parole. Lo spirito è questo, non si ha timore di parlare di felicità di fronte a questa emozione. E noi non siamo abituati a parlare di felicità, solitamente».
Claudio Niniano, anch’egli testimonial di Jameson, disse che la strada dà più libertà di un locale perché è dinamica, consente maggiore naturalezza. È d’accordo?
«È esattamente così. Sono scelte di vita. Chi suona per strada deve avere una marcia particolare perché deve stare al gioco con se stesso. Deve essere egoista, cioè deve cantare per sé, per divulgare quello che ha dentro. Se tu non ti carichi di emotività dentro, non trasmetti niente. È come stare in aereo quando, nei momenti di criticità, viene calata la mascherina con l’ossigeno e l’hostess dice agli adulti: “Prima usufruitene voi stessi, poi datela ai bambini» perché altrimenti è dannoso per entrambi. Caricarsi, e poi dare agli altri. Stare in strada è questo, ed è uno stile di vita, non c’è niente tra te e gli occhi di chi ti ascolta».
A che punto è il percorso d’integrazione della figura del busker in Italia?
«In tante città d’Italia, in passato, regnavano delle leggi comunali di pulizia urbana che vietavano di suonare per strada. Man mano queste leggi sono state modificate, anche perché Ferrara ha fatto scuola. Il musicista ambulante aveva grosse difficoltà: doveva per esempio cambiare il luogo in cui stava suonando ogni cinque minuti, perché non poteva stare per più di questo tempo davanti allo stesso edificio. Oppure non poteva suonare davanti alle chiese. Il festival che abbiamo inventato era talmente fuori dalle regole che stimolò il cambiamento di questa concezione. Questo ha portato a modificare anche la percezione del musicista di strada: i bambini che si avvicinano agli strumenti, gli anziani che ballano, è tutto un dialogo. Per molti anni i busker sono stati tutto ciò che è negativo, nullafacenti, tutto quello che sta verso il basso, poiché erano legati alla strada e in strada trovi chi non ha niente da fare, secondo l’immaginario comune. E poi c’è un altro fattore: la gente non li conosceva. Poi a un certo punto è scattato qualcosa di strano nella mentalità collettiva e sono stati riconosciuti come veri artisti, veri musicisti, un valore aggiunto. Eppure, erano sempre quelli di prima, solo che non si conoscevano la loro storia e la filosofia di vita».
Sogni di grande portata spesso sono di difficile realizzazione e possono rimanere tali. Tu invece sei andato avanti senza paura, Sine Metu. Mi vengono in mente le parole con cui Maurizio Di Maggio ti ha descritto: “Stefano non è un pazzo, piuttosto è un lucido folle, di quelli che sarebbero piaciuto a Steve Jobs. Di quelli che seguono i loro sogni fino in fondo e che con il loro esempio aiutano noi, meno temerari, a realizzare i nostri”. Ti definisci un temerario?
«Un giorno in una scuola dissi una cosa che mi ritrovai poi cucita addosso: se non vieni apprezzato per un’idea è un complimento, perché vuol dire che nessuno ci ha pensato prima. E, se nessuno ci ha pensato prima, tu sei il primo che ne è stato capace. Adesso ci sono tante città che copiano spudoratamente Ferrara. Dopo un paio di mesi da quel giorno incredibile che ha cambiato la mia vita, quando nell’87 il Festival ha trovato modo di realizzarsi, Lucio Dalla entrò nella mia officina. E in uscita mi disse: “Chissà che un giorno non suonerò anche io al tuo evento”. È successo. Io di sogni non ne ho nel cassetto. La mia scrivania non ne ha perché, se avesse avuto dei cassetti mentali, avrei scritto una cosa e dopo un’altra ancora e i fogliettini si sarebbero ammucchiati. E il mio sogno avrebbe fatto la muffa. La mia è una scrivania a cielo aperto. Mi ritrovo in quelle parole, nella temerarietà. I sogni nel cassetto non possono rimanere nel cassetto, fanno tristezza, e ammuffiscono».
Hai altri progetti in serbo per il futuro?
«Mi vengono e vanno. Devo aspettare, come con il caffè, che siano freddi, prima di valutarli».
Secondo te come mai Jameson ti ha scelto come suo testimonial?
«Facendo il fabbro io, nella vita, mi sono inventato una strada. Quando, dopo l’istituto d’arte, non ho accettato di andare a lavorare in uno studio tecnico che mi aveva offerto possibilità come disegnatore, ho detto no al percorso più sicuro e ho scelto un mestiere duro, pericoloso. Questa è stata la mia strada, faticosa, meno battuta e meno scontata. Ci sono cose magiche che ti portano a innamorarti e poi scattano meccanismi che ti fanno dire: ma guarda te dove mi ha portato quella scelta! O quell’incontro, quella coincidenza. Negli anni mi trovo progettista di une vento che è nato lì, dentro quell’officina. Le strade in salita, quelle che si ha paura di intraprendere, sono quelle che ho scalato, senza paura. Fino a quel giorno in cui Dario Franceschini mi ha chiamato dicendomi: “Il sindaco ti vuole parlare”».

Foto di Valen Zhou
Articolo di Francesca La Fata